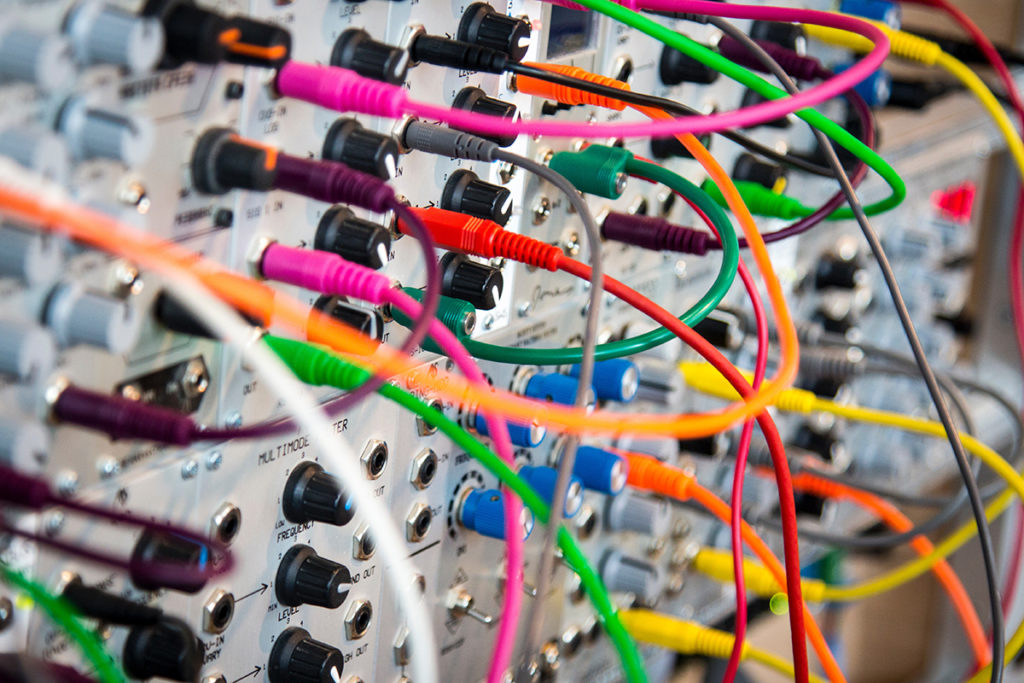La Corte Suprema del Regno Unito, con una sentenza di ottantotto pagine depositata il 16 aprile 2025, ha stabilito che, nell’ambito dell’Equality Act, la definizione giuridica di “donna” deve riferirsi esclusivamente a soggetti nati biologicamente di sesso femminile con la conseguente esclusione degli individui transgender dal riconoscimento legale. La decisione ha origine da un ricorso promosso nel 2018 da For Women Scotland, un’associazione di femministe gender critical, contro il governo scozzese in relazione a una normativa, emanata da quest’ultimo, volta a garantire una quota femminile pari al 50% nei consigli di amministrazione degli enti pubblici. La quota rosa prevedeva anche la presenza di donne transgender in possesso del Gender Recognition Act, ovvero il riconoscimento legale del genere acquisito. Tutto ciò, secondo For Women Scotland, danneggiava, però, i diritti delle donne cisgender: la diretta conseguenza di tale malcontento si traduce nella richiesta, da parte dell’associazione, di una rivisitazione del concetto di “donna” con il fine ultimo di comprendere chi possa realmente rientrare nella categoria1.
Nel 2024 l’associazione ha ottenuto definitivamente l’autorizzazione a fare appello alla Corte Suprema, la quale ha depositato il responso ormai noto: la definizione del sesso di un individuo deve determinarsi su criteri esclusivamente binari e biologici. In tal senso, la sentenza non solo fonda la nozione normativa di “donna” sul sesso biologico, ma nega, al contempo, il riconoscimento di un genere non conforme a quello biologico stesso.
In tale quadro rigidamente binario viene, inoltre, ignorata la tematica relativa agli individui intersex, il cui corpo biologico non rientra nella netta distinzione maschio/femmina presupposta dalla sentenza, con la diretta conseguenza di rendere ancor più evidente il limite strutturale di tale concettualizzazione, poiché la stessa realtà biologica non è sempre binaria.
Riprendendo il pensiero di Judith Butler, filosofa da sempre attiva su questioni relative al genere e alla giustizia sociale, possono essere ritrovati alcuni strumenti fondamentali per decostruire le rigidità identitarie e per interpretare in modo più approfondito la sentenza. Tra le sue opere più rilevanti si può ritrovare Gender Trouble (J. Butler, Questione di genere, Laterza, 2021, p. 43) che appare come un testo fondativo per la comprensione del significato del concetto di genere. Il suo lavoro invita a disinnescare la falsa dicotomia tra i diritti delle donne cisgender e quelli delle donne transgender sottolineando come sia rilevante rileggere la soggettività alla luce di una nuova concezione del genere stesso. Quest’ultimo, infatti, non è un dato biologico quanto, piuttosto, una costruzione culturale e performativa: si diventa donne e uomini attraverso una serie di norme sociali, atti ripetuti e azioni che definiscono che cosa sia realmente parte di un dato corpo.
La sentenza emessa, infatti, nel momento stesso in cui pretende di offrire una definizione neutrale di donna esercita, al contrario, un forte potere normativo decidendo chi ha diritto ad un riconoscimento e chi, invece, ne è escluso. In tal senso, la Corte suprema contribuisce non tanto a fare chiarezza a livello legislativo, quanto a rafforzare un sistema fallato: il punto più controverso di quanto espresso è l’idea che la categoria donna sia un fatto oggettivo e non una categoria politica (Ivi, p. 16). Butler, però, sostiene fermamente l’esistenza di una contraddizione di fondo: definire le persone transgender come “non-donne” non è un atto neutro, anzi, appare come un gesto determinante che sancisce in modo imperativo l’accesso o meno ai diritti, ai luoghi e alla rappresentanza (J. Butler, Fare e disfare il genere, Mimesis, 2014, p. 41).
Patrick Hodge, giudice della Corte Suprema, ha, tuttavia, dichiarato che la sentenza non priva le persone transgender delle tutele contro la discriminazione previste dall’Equality Act2. Nonostante tale precisazione, l’effetto tangibile di questo provvedimento è quello di alimentare una gerarchia normativa tra soggetti che procede in una direzione penalizzante.
Questa dinamica richiama uno dei punti principali del pensiero di Butler, ovvero la critica alla neutralità apparente delle categorie giuridiche. Secondo la filosofa non esistono definizioni totalmente prive di implicazioni, poiché ogni classificazione comporta un esercizio di potere (J. Butler, Questione di genere, cit., p. 24).
È necessario, secondo Butler, allargare il concetto politico di “donna” proponendo una concezione radicalmente democratica e aperta dell’identità: non conta l’origine biologica di un soggetto, quanto il diritto di ogni persona a essere riconosciuta e protetta nel rispetto della propria soggettività.