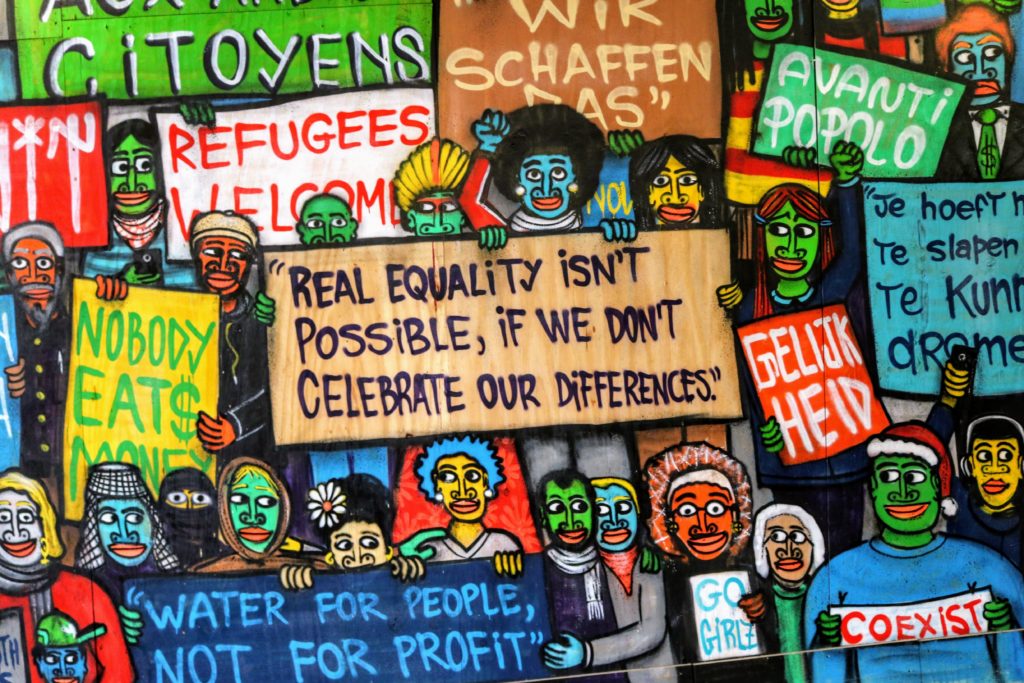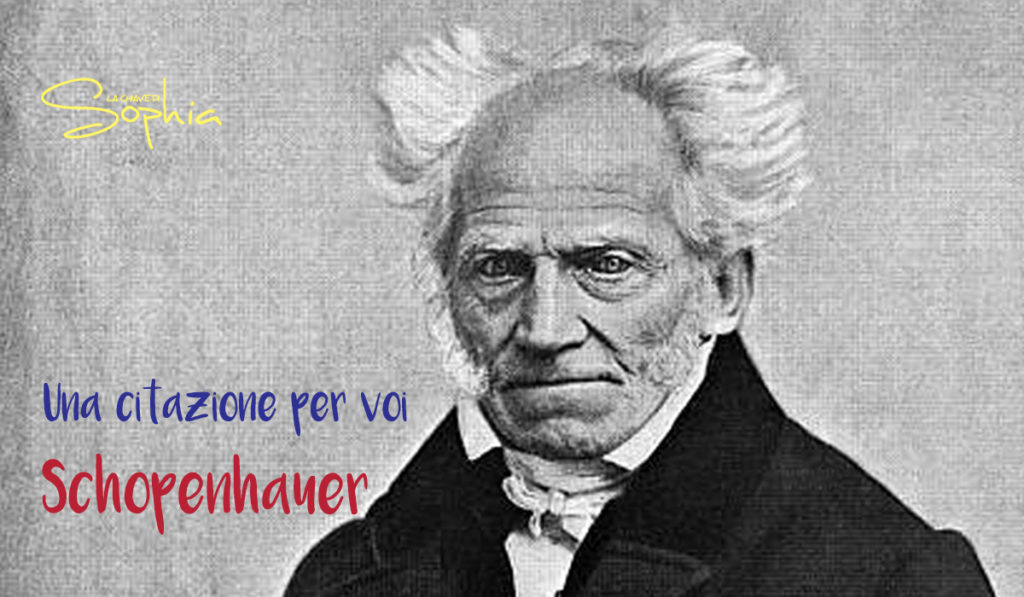Che siamo esseri temporali non serve che ce lo dica Heidegger: è evidente dal fatto che ogni nostra azione è compiuta in vista di qualcosa. Noi stessi siamo progetto: ci pensiamo da qui a sei mesi, un anno, dieci anni. Pensiamo a cosa saremo, a cosa vogliamo essere. Abbiamo speranze, e in generale crediamo che un giorno le cose andranno meglio di come stanno andando ora.
La parola “progetto” significa letteralmente slancio in avanti, davanti a noi. Noi siamo progetto nella misura in cui ci proiettiamo costantemente nel tempo futuro, e in base a ciò che proiettiamo costruiamo il nostro presente per realizzare, cioè per far divenire reale ciò che è presente nelle nostre teste sotto forma di immagine. Così il nostro presente è vissuto da noi retrospettivamente rispetto ad un futuro che ancora non esiste, ma è lì da qualche parte e sta a noi raggiungerlo oppure no.
Questa temporalità, che costituisce la matrice delle nostre coscienze nella misura in cui non siamo completamente assorbiti nel presente ma siamo in grado di esercitare uno sguardo dall’alto rispetto a noi e alla nostra vita, è ciò per cui appunto nutriamo delle speranze ma anche dei timori nei confronti dell’avvenire, poiché se da un lato sappiamo che esso è nelle nostre mani, sappiamo altrettanto bene che in buona parte non dipende da noi. L’ignoto del futuro è uno spazio vuoto che il nostro spirito riempie proiettandovi le sue insicurezze, e prende talvolta per noi la forma di una minaccia. Di conseguenza, il nostro bisogno di essere rassicurati ci induce a ricercare stabilità nel nostro tempo presente, a costruire attorno a noi un contesto stabile, e cioè un contesto in cui ciò che succede possa essere anticipato, senza sorprese di sorta. E a ben pensarci, anche il nostro progettarci nel futuro e costruire il presente in funzione di questa progettualità, non può esser visto come una manifestazione di questa nostra volontà di controllare un futuro che non conosciamo?
In ogni caso, questo nostro bisogno di controllo, questa volontà di fuggire l’ignoto come tale, si traduce nell’abitudine. L’abitudine in effetti è esattamente un processo orientato al mantenimento di una certa situazione, identica, nel tempo. E vista in questo modo, l’abitudine è un tentativo di annullare il tempo, un tentativo di mantenerci sempre identici a noi stessi, identici di fronte al tempo che passa. Essa consiste in fin dei conti in un certo assopimento della coscienza, che finisce con il perdere la consapevolezza del tempo che scorre, e di sé come di una cosa vivente.
Queste dinamiche sono messe in scena in modo magistrale da Dino Buzzati nel suo più celebre romanzo, Il deserto dei Tartari. Qui il protagonista, Giovanni Drogo, passa le proprie giornate come ufficiale sulla fortezza Bastiani, un vecchio avamposto della frontiera su un deserto sconfinato, che ha la funzione di segnalare in tempo l’invasione dei Tartari, che sembra non avvenire mai. Tutto il romanzo è una descrizione della vita interiore del protagonista e del suo combattere tra la volontà di andarsene da quel posto in cui nulla mai succede ed il suo progressivo abituarsi a quella vita, abitudine che, sommata all’isolamento di quel posto, lo rende pian piano estraneo al consorzio degli esseri umani, incapace di riprendere in mano una vita che giorno dopo giorno si allontana da lui, diventa per lui irrecuperabile, senza tuttavia – ed è questa la cosa più inquietante – ch’egli se ne renda conto: «Tutte queste cose erano ormai diventate sue e lasciarle gli avrebbe causato pena. Drogo però non lo sapeva, non sospettava che partire gli sarebbe costato fatica né che la vita della Fortezza inghiottisse i giorni uno dopo l’altro, tutti simili, con velocità vertiginosa. Ieri e l’altro ieri erano eguali, egli non avrebbe più saputo distinguerli; un fatto di tre giorni prima o di venti finiva per sembrargli egualmente lontano. Così si svolgeva alla sua insaputa la fuga del tempo» (D. Buzzati, Il deserto dei Tartari, Mondadori, Milano 2016, pag. 62).
Non racconteremo qui la fine del romanzo, per non privare qualcuno del piacere di leggerlo. Questo breve passaggio è tuttavia sufficiente a metterci in guardia contro i rischi dell’abitudine. Ognuno di noi è confortato dalla regolarità, dagli aspetti ripetitivi della dimensione quotidiana che ci rassicura e sembra metterci al riparo dai pericoli di ciò che non conosciamo. Ma ricordiamoci due cose: la prima, che non c’è nessuna sicurezza reale nella ripetitività, bensì un’apparenza di sicurezza che ci illude, e troppa abitudine atrofizza le nostre coscienze e ci rende incapaci di rapportarci alle novità della vita e di affrontare le difficoltà man mano che ci si presentano davanti. La seconda, che malgrado tutti i nostri tentativi di fermarlo, il tempo scorre, ineluttabile, e il nostro rinchiuderci nell’abitudine può far sì che un giorno ci rendiamo conto che il meglio della nostra vita è passato, senza che noi ce ne siamo accorti. Dentro ognuno di noi c’è una fortezza Bastiani: abbandoniamola finché siamo in tempo.
NOTE
[Photo credit Hadija via Unsplash.com]