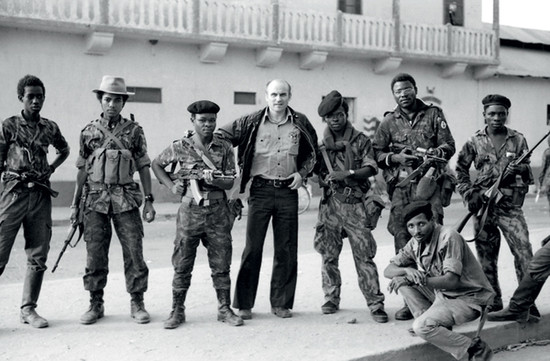«Il termine “giustizia riparativa” rimanda a un ambito concettuale che ingloba presupposti antropologici, questioni filosofiche, dati criminologici, norme giuridiche e prassi dialogico-riconciliative che, nel tempo, hanno concorso a delineare un modello teorico di giustizia autonomo e riconoscibile oltre che una serie di metodologie del fare giustizia aventi come orizzonte la riparazione dell’offesa, del danno e della sofferenza che si generano nell’ambito dei conflitti». (G. Mannozzi, Enciclopedia del Diritto, Estratto, Annali X, 2017)
In Italia, la giustizia riparativa è stata introdotta in modo organico con il decreto legislativo n. 150 del 2022, parte della cosiddetta Riforma Cartabia, anche se si è affermata fin dalla metà degli anni ‘90 con particolare riguardo al contesto minorile, che ne definisce i principi e le modalità di applicazione. Sono previsti programmi specifici per diverse tipologie di reato e fasi del procedimento penale, con l’obiettivo di favorire la responsabilizzazione, la riparazione e la pacificazione.
Il paradigma riparativo si affianca a quelli retributivo e riabilitativo e propone un cambio di sguardo. È un modello che invece di focalizzarsi solo sull’autore del reato per punirlo o per riabilitarlo, lavora sulla relazione rotta dal reato, con la vittima e la comunità. Il reato, per la giustizia riparativa, non rappresenta soltanto la violazione di una norma del codice penale, ma rompe una relazione significativa, un patto di cittadinanza, provoca una ferita sociale. Non si tratta di un sistema alternativo a quello processuale, ma complementare. Non si sostituisce al processo e alle sanzioni, ma si affianca e prova a lavorare non sulle verità processuali ma sulle verità personali. Non è la messa alla prova o i lavori di pubblica utilità. Si può intraprendere in ogni fase processuale e non comporta sconti di pena.
La giustizia riparativa può attivare percorsi che abbiano un concreto valore trasformativo, che tengano conto del dolore delle vittime, della complessità del danno, del ruolo della società, e di stimolare negli autori dei reati una presa di consapevolezza, una reale assunzione di responsabilità. Quella riparativa non è la giustizia materiale, bensì giustizia esistenziale e sociale. Un esempio emblematico di mediazione, e anche uno dei primi in Italia che ha fortemente contribuito a costruire le basi della mediazione in ambito penale e della giustizia riparativa, è quello di Agnese Moro, figlia di Aldo Moro ucciso nel 1978 dalle Brigate Rosse, che dopo molti anni ha incontrato alcuni protagonisti del rapimento del padre. Lo ha voluto fare per “cacciare i fantasmi del passato”. «Non si ripara l’irreparabile, ma abbiamo attraversato insieme i nostri inferni, io e i miei amici difficili e improbabili. – ha detto – La giustizia riparativa si occupa dell’irreparabile».
Un altro esempio è il caso di un minorenne responsabile di un atto vandalico ai danni di una scuola: anziché affrontare un processo penale, il giovane ha partecipato a un programma di giustizia riparativa. Dopo un percorso di mediazione, ha incontrato il preside e alcuni insegnanti, ha ascoltato il racconto delle conseguenze delle sue azioni, ha scritto una lettera pubblica di scuse e ha partecipato attivamente alla tinteggiatura delle pareti danneggiate. In questo caso, il danno non è stato solo riparato materialmente, ma ha generato una trasformazione relazionale e una maggiore consapevolezza del senso di appartenenza alla comunità scolastica.
In ambito adulto, un esempio riguarda un incidente stradale con lesioni. La vittima ha accettato di incontrare l’autore durante un percorso di mediazione. Il dialogo ha permesso alla persona offesa di esprimere il proprio dolore e le difficoltà incontrate nel processo di recupero, mentre l’autore ha potuto chiedere scusa e proporre gesti concreti di riparazione, come il supporto economico per le spese mediche. Pur non modificando l’esito processuale, questo percorso ha favorito una risoluzione emotiva che il tribunale da solo non avrebbe potuto garantire.
A far dialogare le parti è il mediatore che ha un ruolo fondamentale e che non giudica, non impone soluzioni, non interpreta. Offre uno spazio e un tempo per accogliere il disordine del conflitto generato dal reato, e si pone nel mezzo delle complesse dinamiche che caratterizzano il dialogo fra i partecipanti. Il mediatore si pone con equiprossimità, cioè, pur essendo una figura terza rispetto alle parti coinvolte nel conflitto, non è equidistante, ma cerca di avvicinarsi alle parti in modo equo. L’equiprossimità è un bel cambiamento di prospettiva. Anzi, di paradigma.
Parlare di giustizia riparativa oggi è urgente, perché viviamo in una società sempre più polarizzata, in cui la giustizia viene spesso vissuta come strumento punitivo o vendicativo, più che come processo di comprensione e trasformazione. La giustizia tradizionale ha il compito di stabilire la colpevolezza e la pena, ma spesso lascia irrisolto il bisogno di senso, di riconoscimento e di elaborazione che colpisce tanto le vittime quanto gli autori del reato e le comunità coinvolte. La giustizia riparativa apre uno spazio di ascolto, confronto e riconoscimento reciproco, dove è possibile risignificare il conflitto e riconnettere ciò che è stato spezzato. Non si tratta di “buonismo”, ma di responsabilità: riparare non significa dimenticare, ma prendersi cura delle conseguenze del reato in tutte le sue dimensioni. Questo è il potere trasformativo della giustizia riparativa, che può diventare, anche in Italia, una risorsa per umanizzare il sistema penale e rafforzare il tessuto sociale.
NOTE
[photocredits Linkedin sales solutions via Unsplash]