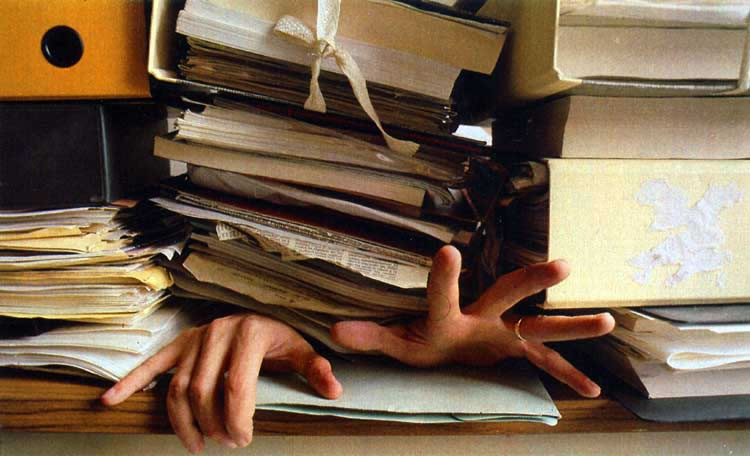La realtà contemporanea si configura come uno spazio all’interno del quale l’essere è stato soppiantato dall’apparire poiché tutto muta continuamente a una velocità spesso inafferrabile. In tale scenario gli individui che costituiscono la società si muovono come una sorta di macchina fagocitante che desidera e consuma tutto ciò che raggiunge: oggetti, corpi e relazioni. La cultura dello spreco ha trasformato l’esistenza in una vetrina spettacolarizzante dove la merce più ambita non è altro che l’immagine irraggiungibile di un sé modificabile.
In questo contesto il corpo degli individui diviene un dispositivo che necessariamente dev’essere sano, efficiente e funzionale poiché strumento primario di riconoscimento sociale. Nello scenario che quotidianamente viene a delinearsi all’interno della contemporaneità ci si può interrogare, però, sul ruolo che assume la malattia intesa come sospensione temporanea di un fluire incessante.
Nella sua filosofia Friedrich Nietzsche, che attraversò una faticosa esistenza a causa di una precaria condizione di salute, attribuisce un duplice significato alla malattia: se da un lato indica una condizione del corpo dalla quale partire per creare una nuova forma esistenziale, dall’altro è rappresentativa del declino della società Occidentale. Concentrando l’attenzione sul primo aspetto, si può affermare che la sua riflessione sia orientata alla comprensione del dolore come elemento di autenticità e disvelamento dell’identità. Il corpo, infatti, si conosce realmente mediante la sofferenza1. In tal senso, la vita viene assunta apparentemente come un peso, ma proprio tale complesso e quasi faticoso approccio alla stessa permette di fare quanti più esperimenti possibili nella sfera morale, poiché il corpo malato costituisce il punto di partenza per il pensiero creativo.
Nietzsche fa coincidere, così, la corporeità con il pensiero stesso aprendo un profondo bivio per cui, da un lato, le idee prodotte non devono subire il condizionamento negativo che potrebbe esercitare su di esse la malattia, dall’altro però la sofferenza è rivelatrice sul piano del pensiero2. Da ciò si può dedurre il fatto che il dolore corporeo sia concepito come uno stato di coscienza che permette all’essere umano un’analisi introspettiva più approfondita e una visione decostruita di ciò che lo circonda. Nietzsche sostiene, infatti, di provare lietezza nella costante sete di conoscenza che nasce dalla malattia stessa ed è proprio questo che gli ha permesso di superare il tormento e la disperazione patita a livello fisico3.
Il corpo malato si configura come una frattura esistenziale che sancisce una cesura tra un prima e un dopo. La corporeità diviene, infatti, luogo di verità, di trasformazione e scenario in cui si manifesta la possibilità tangibile di una nuova esperienza umana. Chi affronta, ad esempio, una condizione fisica cronica o attraversa una diagnosi inaspettata vive una profonda mutazione della percezione della temporalità, così come ridefinisce gli stadi di priorità direzionando il proprio agire verso un corpo che si impone come protagonista assoluto di un ascolto necessario. Nel contesto contemporaneo la sofferenza viene spesso reinterpretata, anche attraverso i social network, per condividere una narrazione della corporeità malata come veicolo di consapevolezza e solidarietà, basti pensare ai numerosi account Instagram che, mediante un linguaggio comunicativo forte, divengono luoghi digitali di sensibilizzazione. Questa modalità di affrontare il dolore supera, almeno in parte, una disgregazione identitaria che si può ritrovare anche in figure come Frida Kahlo, che ha trasformato il corpo ferito in uno strumento artistico, o Marina Abramović, che ha utilizzato la corporeità spingendola al limite attraverso atti performativi di denuncia sociale.
Parallelamente, il ricorso a pratiche terapeutiche integrate, come la mindfulness applicata al dolore, lo yoga terapeutico, l’arteterapia o il teatro sociale, sancisce un cambiamento di paradigma: il dolore non viene esperito come oggetto di competenza medica da eliminare, ma come esperienza intenzionale di consapevolezza. Nietzsche, a tal proposito, in Ecce Homo afferma che «La malattia mi ha dato il diritto di cambiare tutte le mie abitudini» (F. Nietzsche, Ecce Homo, Einaudi, Torino 2005, p. 98), sottolineando come la situazione di crisi apra lo spazio ad una nuova domanda circa la radicalità della propria esistenza. La sofferenza, infatti, interrompe le logiche dell’automatismo adattativo dei soggetti con l’intento di destabilizzare il conformismo di massa e di rivelare nuove pratiche di cura del sé.
Nasce, dunque, un nuovo modo di leggere la grande salute: il corpo sano non è semplicemente armonia delle parti, quanto, piuttosto, una forza capace di attraversare il dolore riconoscendo la malattia stessa come parte costitutiva dell’esperienza umana. La sofferenza non è solo passivo annientamento, ma si configura come l’atto più autentico di libertà.
NOTE
1. Cfr. F. Nietzsche, Ecce Homo, Einaudi, Torino 2005, pp. 123-124.
2. Cfr. ibidem.
3. Cfr. F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Adelphi, Milano 2001, pp. 45-46.
[Photo credit Klara Kulikova via Unsplash.com]