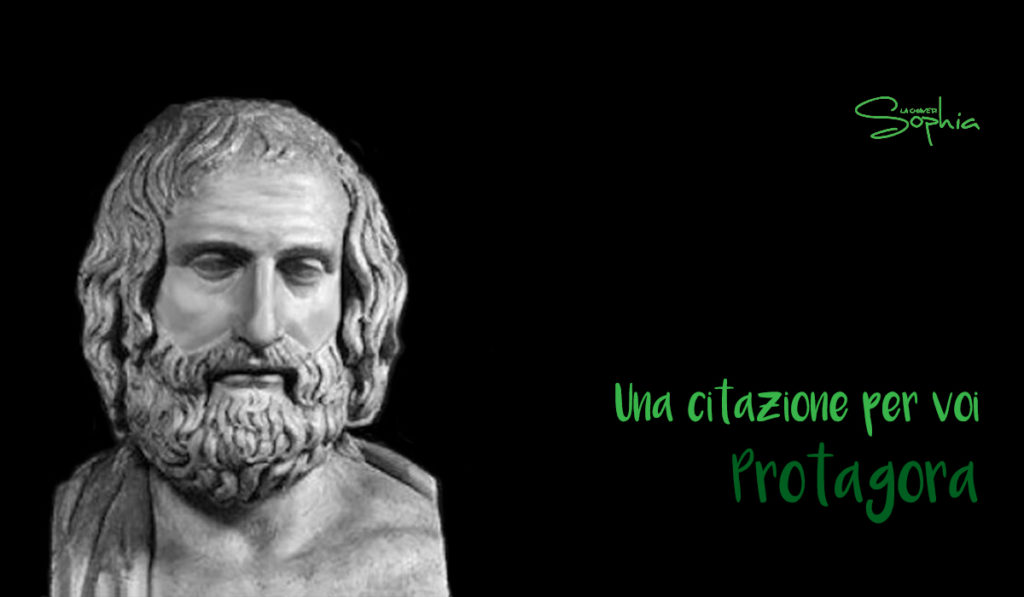Un contributo specifico di Ivan Illich, tra antropologia e filosofia.
Il dolore è cio che esprime il sintomo di un confronto, di una relazione con la realtà. Salute e sofferenza, in termini di sensazioni vissute e consapevoli, sono fenomeni propri del soggetto umano. La salute, come responsabile e intima interpretazione di un determinato copione sociale, rinvia al senso che l’individuo riconduce al proprio corpo, che trova origine e sviluppo nella relazione che egli intrattiene con il mondo circostante, con le altre forme di vita. Il senso del corpo, così, si configura quale dono di una cultura che si rinnova continuamente. Quando questa subisce un processo di medicalizzazione, la struttura tradizionale delle usanze viene implacabilmente pietrificata da un sistema specificio e meccanico di codici medici. Ognuno di noi apprende, dal contesto culturale in cui si trova a vivere, come soffrire, come guarire e morire: tuttavia queste concrete realtà sono ora rivendicate dalla tecnocrazia alla sua gestione e finiscono con l’essere trattati nei termini di vere e proprie disfunzioni da cui l’uomo[1] deve essere sgravato grazie all’intervento di strumenti istituzionali.
A differenza delle culture tradizionali le quali, in quanto sistemi di significati, rendono tollerabile il dolore integrandolo in una situazione carica di senso, la civiltà cosmopolita incentiva il distacco del dolore, da ogni contesto soggettivo o intersoggettivo, polverizzandolo. Così il dolore viene a configurarsi quale “maledizione sociale”, e non più quale male naturale, per sopprimere il quale il sistema industriale dispensa all’individuo sempre nuove medicine.
Se per le culture tradizionali il dolore è concepito come disvalore intimo, intrinseco alla natura umana e incomunicabile, al contrario per la civiltà medica, in primo luogo occidentale, esso è soprattutto una reazione organica che è possibile schedare, quantificare e misurare: è la professione medica a stabilire quali sono i dolori autentici, quali quelli psicosomatici, quali quelli immaginari e infine quelli che noi “simuliamo”.
Affinché un determinato dolore vissuto possa costituire e rappresentare una sofferenza nel senso pieno e profondo del termine, è necessario collocarlo in un quadro culturale. Oggi più che mai il “funzionario della medicina” mira in primo luogo al trattamento e non alla guarigione del paziente. Il medico, infatti, non è stato preparato a comprendere gli interrogativi che il dolore suscita in colui che soffre in quanto è stato educato a ridurre l’insieme dei dolori provati ad un elenco di disturbi, raccolti in un dossier: convincendosi di saper gestire la meccanica del dolore, può facilmente eludere l’invito del paziente alla compassione. Eppure presso Ippocrate e i suoi discepoli il dolore rappresentava un utile strumento di diagnosi. Riconducendo un dolore a una determinata forma di armonia, grazie allo specifico dolore denunciato dal paziente, i medici dell’antica Grecia potevano facilmente capire quale tipo di armonia il paziente dovesse riacquistare per tornare in salute. Il progresso successivo della civiltà poi, però, ha portato alla riduzione del volume complessivo della sofferenza: la politica ha iniziato a essere intesa quale attività mirata a ridurre al minimo il dolore piuttosto che a massimizzare la felicità.
In questo contesto sembra ormai razionale fuggire il dolore, letteralmente a qualsiasi prezzo, piuttosto che fronteggiarlo. Sembra ragionevole eliminare il dolore, anche a costo di perdere l’indipendenza. Sembra mentalità illuminata considerare inesistenti tutti i problemi non tecnici sollevati dal dolore, anche se ciò significa trasformare dei pazienti in animali domestici […]. In una società anestetizzata occorrono stimoli sempre più forti perché si abbia il senso d’essere vivi[2].
Il paziente oggi è educato a trovare il piacere nell’asservimento ai prodotti industriali: ricordare che la sofferenza è un’attività responsabile gli risulta una pura follia. Egli si ritrova a giustificare il suo passivo stile di vita additando come insensata, irrazionale, quasi masochistica, qualsiasi partecipazione personale nel confronto inevitabile con il dolore; ma la soppressione del dolore è ciò che trasforma ognuno di noi “in un insensibile spettatore della decadenza del proprio io”[3].
L’uomo occidentale ha perso il diritto di presiedere all’atto di morire e viene privato della libertà di scelta su di sé e sulla propria salute. Per l’autore, l’esperienza del dolore è un fatto tanto culturale quanto soggettivo: vi sono culture in cui esistono dolori che in altre non sono contemplati così come culture in cui il dolore viene considerato come naturale, come parte determinante della vita: così la cultura plasma, dà forma e intensità al dolore. Tuttavia, nel caso dell’occidente, il sistema della medicina ha impedito all’individuo di poter riconoscere significato al dolore. È la patologia (e non più l’uomo) a costituire e caratterizzare il centro focale del sistema medico.
L’uomo diviene un paziente che delega ad altri (al medico, al sistema sanitario) il suo intimo confronto con la morte: il soggetto ha perso il contatto con la fine terrena della sua esistenza. La iatrogenesi emerge, così, nelle forma della univoca e cieca dipendenza delle persone dalla medicina. Quest’ultima stabilisce che una certa categoria di persone è malata e così, conseguentemente, si espande sempre più il suo potere di condizionamento sociale.
[…] La burocrazia medica suddivide gli individui in: – quelli che possono guidare l’automobile, – quelli che possono assentarsi dal lavoro, – quelli che devono essere rinchiusi, – quelli che possono fare il soldato, – quelli che possono andare oltre frontiera, fare i cuochi o praticare la prostituzione, – quelli che non possono aspirare alla vicepresidenza degli Stati Uniti, – quelli che sono morti, – quelli che sono in grado di commettere delitto e – quelli che sono responsabili di averlo commesso[4].
La conclusione di questa corsa contro la libertà è che oramai il cittadino, finché non si prova che è sano, si presume che sia malato. Come “naturale” conseguenza di questo, i nomi della vita quotidiana appaiono sempre più depauperati della loro capacità di essere serbatoio di senso per dare significati a dolore e sofferenza, rendendo così dolore e sofferenza sempre più incomprensibili e sempre meno sopportabili.
Riccardo Liguori
NOTE
[1] Come ricorda Illich, pensando all’opera Zoologie und las neue Bild des Menschen di Adolf Portmann, l’uomo non possiede meccanismi evolutivi congeniti che lo guidano a un equilibrio. Infatti è solo grazie alla sua disponibilità creativa che il soggetto riesce a conferire al suo ambiente caratteri diversi da quelli ch’esso presenta per altre specie: lui solo, cioè, trasforma l’habitat in casa.
[2]Ivan Illich, Limits to medicine – Medical Nemesis: the expropiration of health, Marion Boyars, Londra, 1976; tr. it. a cura di Donato Barbone, Nemesi medica. L’espropriazione della salute, Mondadori, Milano, 2004, pag.157.
[3] Ivi, pag. 159.
[4] Ivan Illich, Nemesi medica, pag. 68.