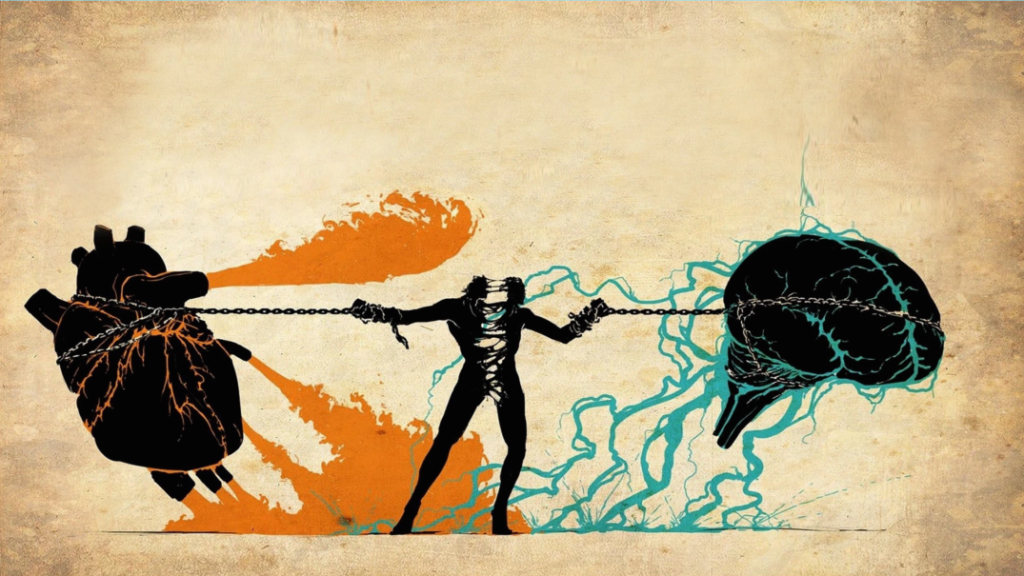Prima di leggere il libro I miei sette figli, di Alcide Cervi e Renato Nicolai, la mia conoscenza riguardo la storia della famiglia Cervi si limitava a una sola canzone. Le parole del testo mi avevano fatto percepire in modo abbastanza chiaro sia la trama della vicenda, sia il tragico epilogo di quest’ultima. Ignoravo però quanta rilevanza questa storia avesse avuto nell’immaginario collettivo del dopoguerra italiano, non avevo idea dell’esistenza di un libro e non immaginavo affatto che le varie edizioni di quest’ultimo fossero state più o meno manipolate o revisionate dal Partito Comunista a seconda degli obiettivi politici che nei vari anni si era proposto.
Ad essere sincera, limitandomi alle sole parole della canzone, quella dei Cervi mi era parsa una storia come tante altre di quell’epoca, e in questo probabilmente non mi allontanavo molto dal pensiero del capofamiglia Alcide. Certo, però, che vi è un’indubbia differenza tra l’avere ingenuamente un tale pensiero, e il constatare una sua certa conferma nelle parole stesse del protagonista. Effettivamente, tra le pagine iniziali del libro, Alcide Cervi afferma che la storia della sua famiglia «non è straordinaria, è la storia del popolo italiano combattente e forte». Non ho potuto non soffermare la mia attenzione sulle possibili motivazioni che avevano generato questo genere di affermazione; il fatto che una frase così forte fosse stata pronunciata da quello stesso padre che aveva perso tutti e sette i suoi figli maschi a causa di una rappresaglia fascista, aveva decisamente scombussolato le mie aspettative. La consapevolezza e la fermezza di pensiero che trasparivano dal racconto, e che dimostravano il grado della sua rielaborazione rispetto a quanto era accaduto, personalmente, almeno in prima battuta, mi hanno un po’ turbata. Proseguendo la lettura, però, ho avuto modo di percepire quello che poteva essere stato l’intento che Alcide si era potuto proporre pronunciando quelle parole: probabilmente, egli voleva avvicinarci all’idea secondo la quale nessuna storia analoga a quella vissuta dalla sua famiglia, nessuna storia di vita, di guerra, di morte, legata al particolare periodo storico che si viveva all’epoca, avrebbe potuto meritare l’aggettivo di “straordinaria” a discapito di altre storie dello stesso tipo. Alla luce di questa considerazione, sono riuscita così a capire anche per quale motivo egli non ponesse alcuna differenza tra la morte di tutti e sette i suoi figli e la morte di un solo figlio, se questo è l’unico che si ha. Inizialmente, però, per quanto la storia dei Cervi poteva essermi sembrata una storia come tante altre, non riuscivo ad accettare che la narrazione dello stesso Alcide paresse andare nella medesima direzione dei miei iniziali ed ingenui pensieri, che peraltro avevo accantonato con facilità e prontezza.
Quella dei Cervi, a mano a mano che continuavo la lettura, mi sembrava sempre più una storia pesante, rilevante, emblematica, pur nella sua indubbia semplicità. Dal capofamiglia Alcide, quindi, io mi aspettavo di più; era come se volessi scovare in qualche modo una crepa, un cedimento, una debolezza, all’interno della sua struttura di uomo tutto d’un pezzo. Avrei infatti voluto chiedergli: “come può la morte non essere valutata anche in termini quantitativi?”. La mia, poteva essere una presa di posizione piuttosto comune: siamo infatti abituati a valutare come più o meno grave un certo avvenimento a seconda delle vite che questo ha interrotto. Ma l’immutabilità del testo scritto, attraverso la sua statica autorevolezza, sembrava suggerirmi che il vecchio Alcide, il suo pensiero, non l’avrebbe proprio rivisto. Mi sono chiesta, allora, se il ragionamento sulla morte in termini quantitativi sia da considerare come dovuto al naturale orientamento della nostra sensibilità o se piuttosto siamo indotti a ragionare in questo modo facendo memoria delle pagine negative della storia del secolo scorso, o percependo l’eco delle grandi catastrofi naturali che costantemente e inevitabilmente sfidano il nostro controllo sul mondo che ci circonda. Mi pareva che Alcide Cervi (e a tal proposito mi permetto di far notare una differenza profonda rispetto alla tendenza dei meccanismi e delle logiche dell’informazione attuale, la quale guarda per esempio a fatti di cronaca e ad attentati terroristici con un’attenzione e una curiosità talvolta morbose) non avesse invece alcun dubbio nel riflettere sulla morte in termini soprattutto qualitativi: egli sembra insegnarci che morte è sinonimo di perdita, e in quanto tale deve sempre essere presa in considerazione con assoluto rispetto e con dolore autentico, qualsiasi portata essa abbia.
Credo che l’importanza di un ragionamento di questo tipo sia assolutamente da rivalutare: quando si parla di morte, infatti, forse si dovrebbero accantonare i freddi e spogli dati numerici, in vantaggio di un approccio meno scientifico e più umano. Se inizialmente avevo dunque quasi additato il pensiero di Alcide Cervi, poiché mi pareva povero di quegli elementi emozionali che io invece ritenevo lui dovesse avere, dopo questa serie di impegnative riflessioni riuscivo invece ad apprezzarne la sua attenta e meditata profondità.
Ed è probabilmente grazie a queste sue profonde convinzioni che dopo la fucilazione dei suoi sette figli è riuscito subito a guardare avanti, ai bisogni della famiglia, in particolare degli undici nipoti, e ai bisogni del podere. La sua è una vera opera di ricostruzione, emblematicamente rappresentata dalla frase «dopo un raccolto ne viene un altro»; un’altra frase forte che però fa porre l’attenzione di noi lettori sulla sua volontà di essere riferimento, sicuro e tenace, per coloro che erano rimasti. Da questo punto di vista, mi sembra che Alcide sia proprio quel nonno che in molti avremmo voluto avere.
Federica Bonisiol
Il testo I miei sette figli, pubblicato nel 1955, ebbe origine da un lavoro di inchiesta che portò l’autore Renato Nicolai ad intrattenere una serie di conversazioni con Alcide Cervi. Essendo Nicolai un giornalista inviato del Partito Comunista, si ritenne probabile il fatto che le memorie di Alcide potessero essere state plasmate per fungere da sostegno ai vari obiettivi politici che il Partito si propose nel corso degli anni; ciò risulta particolarmente evidente dal confronto tra la prima edizione e quella del 1971, nella quale alcune frasi hanno subito modifiche radicali. Malgrado questo, grazie alla vasta diffusione del testo (venne tradotto in 14 lingue) e grazie a una serie di cerimonie pubbliche, quella della famiglia Cervi divenne ed è tutt’ora una delle storie più esemplari e più commoventi per potersi avvicinare – in punta di piedi – allo studio della Resistenza.
COLLEGAMENTI:
Video Youtube: qui