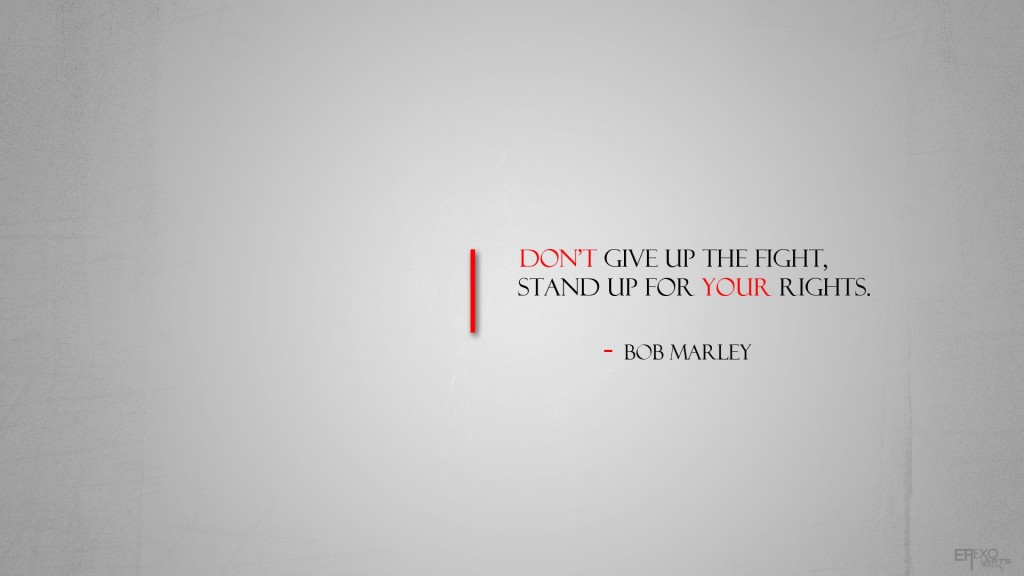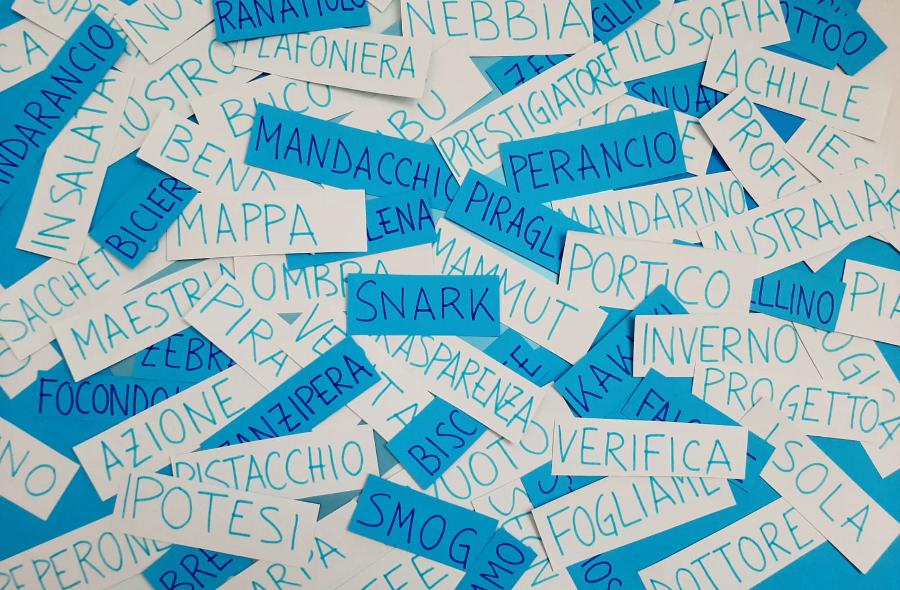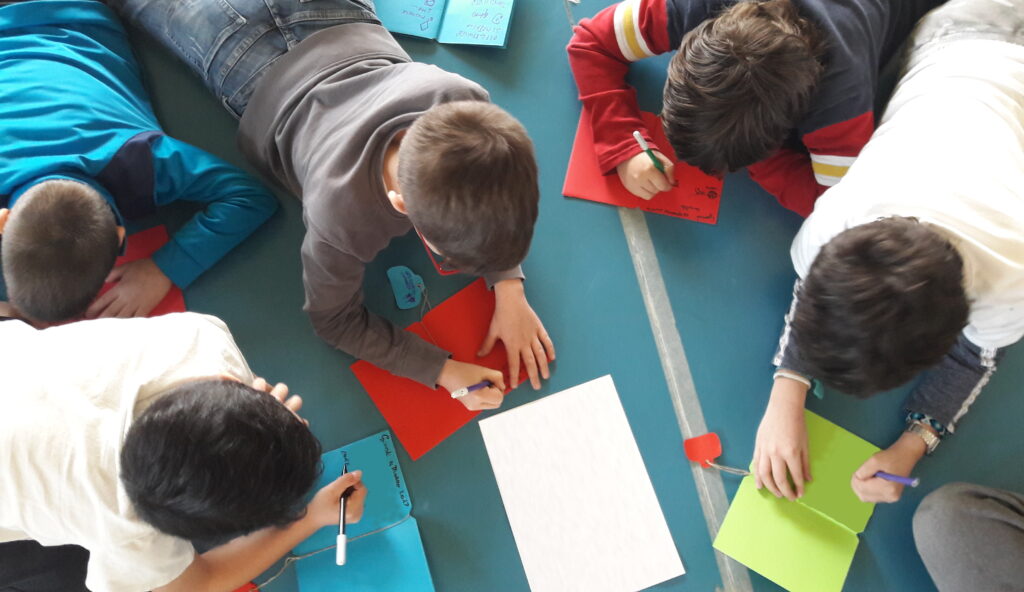Tutti i grandi progettisti di giochi, siano essi giochi da tavolo, di carte o videogiochi, concordano nell’affermare che ogni essere umano è stato un game designer nella sua vita, esattamente durante la sua infanzia, quando tutti inventiamo giochi spontaneamente e liberamente. Tuttavia, crescendo ci dimentichiamo di questa abilità innata. Il game designer non è altro che una persona che si ricorda come si gioca e come creare giochi.
Si potrebbe ritenere che il bambino, oltre ad essere un grande game designer dalla fervida immaginazione, sia anche, almeno potenzialmente, un filosofo. Basti pensare alla cosiddetta “età dei perché”, quando il bambino, mano a mano che verso i 2-3 anni diventa sempre più consapevole del mondo che lo circonda, prova un senso di grande meraviglia e stupore, e dunque chiede il perché di ogni cosa. È evidente che a quell’età il bambino non dispone ancora delle capacità logico-razionali che lo potrebbero rendere un filosofo, ma si potrebbe, forse, considerare questa fase come una sorta di sentimento o pre-sentimento filosofico, una pre-filosofia. Insomma, a quell’età il bambino è un filosofo in potenza, poiché, a fronte della meraviglia di aristotelica memoria, si pone domande relative alle cause e alle essenze, pur non essendo consapevole di questo. Una sorta di filosofia inconscia. Dunque, se i bambini sono sia game designer che filosofi e se tutti, come è vero, siamo stati bambini, l’applicazione di principi e tecniche tratte dai giochi al sapere filosofico potrà forse sembrare meno peregrina.
Qui può tornare utile parlare di gamification, termine che Yu-Kai Chou ha coniato e approfondito, e che sostanzialmente consiste nell’introdurre ciò che di divertente ed eccitante vi è nei giochi all’interno di contesti non ludici, come il lavoro o l’apprendimento scolastico.
Un esempio recente di gamification applicato alla progettazione di un corso di filosofia universitario in Russia è descritto nel saggio Gamified approach to blended philosophy course di Mikhail Bukhtoyarov e Anna Bukhtoyarova. In Russia, l’attivazione di corsi di filosofia a ogni livello universitario è obbligatoria in qualsiasi facoltà. È perciò comprensibile che gli studenti, specialmente di facoltà tecniche, lo trovino noioso e inutile per la loro vita e crescita accademica e professionale. L’intento del corso “gamificato” era appunto quello di creare interesse per questa materia così astratta e apparentemente inutile, promuovendo abilità di ricerca sociale, lavoro in gruppo, sviluppo di emozioni e relazioni positive, abilità di comunicazione efficaci e creazione di senso e soddisfazione. In particolare, in questo saggio viene citato l’esempio della “caccia al filosofo”, in cui agli studenti che avessero voluto partecipare al progetto (la libertà è condizione indispensabile per l’approccio ludico) veniva chiesto di attivare delle reti di comunicazione sia tramite internet e i social media, sia attraverso amici e famiglia, per trovare un filosofo di una qualsiasi università in tutto il mondo, cui porre un set di domande relative alla storia della filosofia. Se il tentativo avesse avuto successo, venivano assegnati dei punti bonus per il conseguimento di una comunicazione efficace. Era poi richiesto di presentare il risultato della ricerca in un breve saggio.
Questo approccio ludico alla filosofia è stato un successo: la maggior parte degli studenti che hanno partecipato ha affermato di avere trovato l’esperienza positiva e stimolante. Tale risultato, secondo gli autori del saggio, è legato al fatto che il corso è stato progettato non tramite la mera attribuzione di punti o il superamento di livelli (elementi che fanno riferimento alla motivazione estrinseca), bensì cercando il coinvolgimento emotivo e relazionale in un’ottica costruttivista che mira allo sviluppo di abilità comunicative e sociali (si tratta in questo caso di motivazione intrinseca a lungo termine).
A questo punto del discorso non deve meravigliare che già da molti anni si parli di Philosophy for children, un approccio filosofico che si rivolge ai bambini di ogni età e che cerca di sviluppare nella “comunità di ricerca” abilità cognitive complesse di pensiero critico e capacità di empatia, comunicazione e costruzione collettiva di significato. Tutto questo ovviamente nel rispetto dei limiti cognitivi dell’età infantile.
In conclusione, come nel gioco così nella filosofia applicata al quotidiano e alla vita concreta, ciò che conta non è la memorizzazione e la riproduzione di contenuti da manuali o appunti per essere poi magari sottoposti e verifiche ed esami, bensì il senso di appartenenza ad un gruppo, ad una comunità che condivide interessi comuni. Tale comunità non annulla l’identità individuale, ma la rafforza e la rende più solida, in un’ottica di sviluppo sano dell’individuo.
Questi dunque sono i benefici del gioco e della filosofia.
Francesco Breda
Dai 10 ai 22 anni ho studiato al Conservatorio di musica, dove mi sono diplomato in pianoforte con 10 e lode e ho conseguito brillantemente il Compimento medio di Composizione. Ho quindi studiato privatamente direzione d’orchestra per tre anni e mi sono laureato triennale in Filosofia con 110 e lode. Sono risultato finalista in un’edizione del concorso internazionale di composizione musicale “Maurice Ravel” e ho ottenuto una menzione speciale. Recentemente ho conseguito la più alta e prestigiosa certificazione rilasciata dall’università di Cambridge per la conoscenza della lingua inglese, ovvero il C2 Proficiency. Con l’editore Danilo Zanetti in Montebelluna ho pubblicato un libretto di mie personali riflessioni sulla musica e la filosofia, intitolato “De musica et philosophia”. Con il medesimo editore un altro mio libretto, “Teoria musicale e filosofica”, è stato recentemente pubblicato. Mi occupo prevalentemente di composizione e improvvisazione musicale, e dei rapporti tra musica e filosofia. Ho un canale Youtube in cui pubblico mie composizioni musicali originali e che si può trovare cercando su Youtube “Francesco Breda piano composition” oppure, per avere un esempio di una mia composizione, “Francesco Breda Come Sweet Death Extended Golden Ratio”.
[Photo credit unsplash.com]